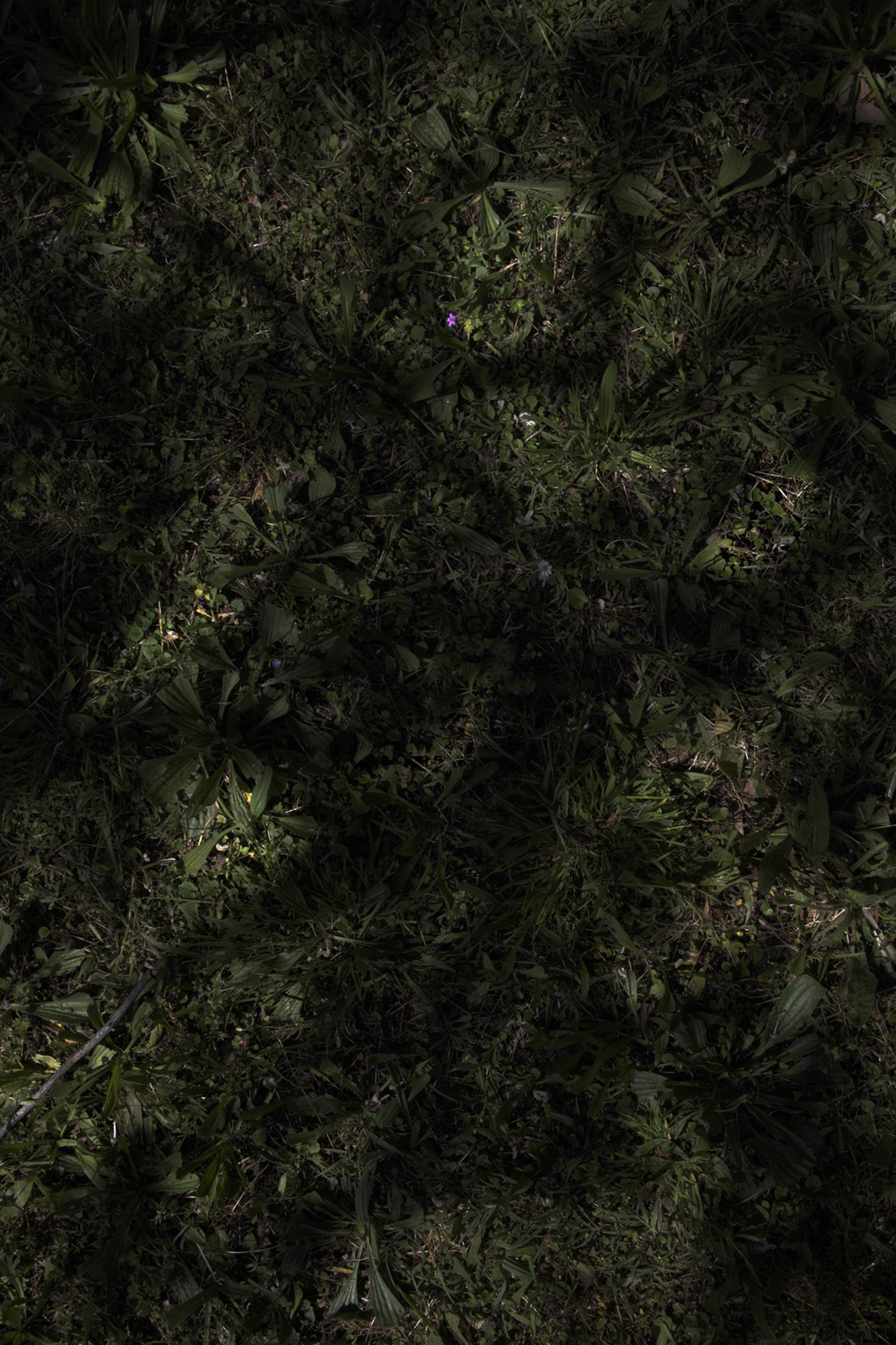Lo scrittore/scrutatore osserva e riporta il mondo su un foglio di carta: definendolo attraverso parole e coordinate definisce un mondo spaziale e figurativo che si osserva e legge parallelo al suolo.
I
Gli abitanti di questa città mangiano velocemente e poi restano seduti o sdraiati per ore su una panchina, su degli scalini, per terra. Non leggono, non dormono, pensano, sognano.
Sembrano essere in attesa.
La città è invasa da sogni e da pensieri e ai milioni e milioni di visioni e desideri che questi uomini regolarmente hanno, oggi e in questi giorni, si aggiungeranno anche i miei. L’aria, densa d’inquietudine, considerazioni sulla morte e su identità culturali violate, sfiora le teste chine. Lo smog esiste ed insiste nei giardini, nelle grandi arterie, nelle strette viuzze del centro antico ed in ogni luogo e poro di questa megalopoli. Brucia gli occhi, secca la pelle, assottiglia le labbra. Qui vicino c’è la piazza più importante della città, la più grande del mondo. Mi sono seduto, invece, su una panchina nei giardini centrali: una piazza alberata e ricca di verde, con panchine e camminamenti. La preferisco all’altra perché si sente il vissuto degli abitanti di questa città: da qui i turisti passano, non sostano. Questa città, così si dice, e forse a ragione, è pericolosa.
Intorno a me oziano persone, più in là al riparo degli alberi, in uno dei bordi della piazza uomini di una certa età giocano a scacchi.
Lì regna un silenzio che solo raramente è interrotto da brevi seppur stentoree esclamazioni. Il silenzio diminuisce man mano che ci si avvicina al palazzo delle belle arti lì dove studenti schiamazzano, e i soliti turisti prendono quelle foto dai sorrisi e dalle pose rumorose; oppure quando ci si avvicina alle strade trafficate che peccano di direzioni cardinali e solcano lo spazio. Su queste vie si affacciano saldi ma tumefatti i palazzi coloniali di questa immensa città che secoli addietro sorse e visse su un vasto lago oramai quasi completamente arso.
Passa una coppia di poliziotti a cavallo che dall’alto del dorso e col petto in fuori sorridono crudi e ammiccanti alle donne mentre guardano agli uomini con draconiana severità.
Tutto passa tranquillo, dal cavallo del poliziotto alla signora vestita da lavoro con le scarpe di gomma, al gentile signore che chiede l’elemosina, alla ragazza che vende con voce dolce e un genuino grande sorriso bianco le pannocchie di mais abbrustolite. Le sigarette, se vuoi, le compri anche singolarmente.
Forse ieri, sicuramente oggi e forse anche domani c’è una luce che non c’è. Nuvole distinte non ce ne sono, forse l’intera città è coperta da un’unica enorme e spessa coltre di biancastri cristalli semi trasparenti.
La luce è schietta e rara ma non vi sono ombre distinte. Solo gli alberi parano l’inondazione di questo chiarore rarefatto denso di credenze, inquietudini e pulviscoli mortali.
Questa luce che non c’è rassomiglia alle persone che qui sostano nell’attesa di qualcosa o del niente. E così, all’ombra che non c’è, nascono i pensieri che ci sono: l’un l’altro si aggregano e amalgamano formando nuvolette che mischiandosi e fondendosi fra di esse e loro con l’aria avvelenata creano l’ombra e la luce che non ci sono.
In un tempo che trascorre senza tempo, alla ricerca di se stesso e della sua propria identità ognuno sosta e resta.
IV
La piazza è in discesa. O in salita. Dipende da dove la si guarda.
Sono seduto nella parte alta dello spiazzo lì dove ancora c’è sole, non lontano dall’ombra irregolare che la ricopre in buona parte.
La forma della porzione scura è costituita dal profilo dei tetti delle case e dei palazzi che diritte una accanto all’altra compongono e sono il lato della piazza che non appartiene al grande palazzo che maestoso la avvolge per gli altri tre lati, creandola.
Questo è un luogo di sosta. Una sorta di area di servizio per turisti accaldati e dai piedi gonfi. Salva la pendenza del piazzale tutto, intorno, è surrealmente e fortemente perpendicolare al suolo. Questo luogo, credo, sarà o sarebbe piaciuto a Giorgio De Chirico e a Bill Brandt.
Alla mia sinistra la ragazza bionda con le infradito di gomma e gli occhiali neri è sdraiata sull’asfalto. Legge un libro che ora ripone sul petto perché parla al telefonino. Le persone che ho davanti e vicine a me sono quasi tutte sdraiate al riparo dal sole, hanno le gambe accavallate e i piedi nudi, le braccia sotto la nuca, gli occhi al cielo. Il busto di una figura sdraiata visto dalla sua stessa altezza è pesantemente immobile. La ricercata posizione delle braccia e i movimenti delle gambe sono il solo segnale della presenza della vita del corpo coricato. Chiunque si trovi qui e qualsiasi cosa ci faccia tiene accanto sé a una bottiglia d’acqua, una lattina, qualcosa da bere. La ragazza con le giapponesi nere ha le gambe diritte e i piedi incrociati, uno dondola sull’altro. Qualcuno lascia questo lato della piazza. Il sole si abbassa veloce, l’ombra si alza ed anche io adesso faccio parte di coloro che stanno nella parte non soleggiata, mi resta solo un po’ di luce sul viso, mi giro per vedere la mia sagoma proiettata per sapere fino a dove esattamente il sole mi colpisce: una parte della mia testa appare sulla pavimentazione insieme alla proiezione dei tetti dei palazzi di fronte.
Le finestre dei caseggiati sono chiuse come se fossero disabitati. Solo nel palazzo di fronte a dove siedo, al piano nobile, ce ne sono due aperte. Dalle aperture si scorge un grande salone dove una scultura forse bianca di gesso o di marmo immobile riposa. Rappresenta probabilmente un vaso con un grande fiore o forse un mezzo busto di donna con una capigliatura ricercata, ma da qui non posso capire di che cosa si tratti precisamente e probabilmente ed in un certo modo anche per questa visione vale la regola del “da dove la si guarda”. La ragazza con le giapponesi nere si è stirata. Ha sgranchito sia le braccia che le gambe e poi si è rimessa a leggere e, sempre con le gambe stese, ha ripreso a far dondolare i piedi uno sull’altro.
La destra della piazza è ancora assolata perché gli edifici lì sono più bassi e così mentre la parte dove io siedo si svuota l’altra rimane vivace di persone e di colori. Questo spazio quindi si divide in due sezioni una di luce e una di ombra; una viva ed una che viene velocemente abbandonata e presto resterà pressoché vuota di persone.
Due scie di aerei formano nel cielo una grande X. Vedo in alto nell’azzurro le rondini che io amo da sempre e credo per sempre.
Domani sarà un’altra bella giornata.
Perché volano alte, le rondini, non si sentono.
V
In quella città che è circondata dall’acqua ed è attraversata dall’acqua, fra le tante e più belle piazze che fra vicoli, strade e canali aprono spazi, ce n’è una che, adesso, fluttua e galleggia nella mia mente. Tre negozi si affacciano nel campiello ed in uno di questi mi attende un pensiero, il regalo di una donna. Lì ho scattato delle fotografie in una grigia mattina di aprile. Ci sono – o chissà – forse c’erano quattro panchine di cui una rovinata dall’umidità, dalla salsedine e dal tempo e due alberi che quel giorno, con i tronchi neri di acqua, invocavano l’arrivo della primavera. Forse per i due alberi ossuti la nuova stagione non arrivò mai. Il nero che affliggeva i loro corpi probabilmente altro non era che un male incurabile.
Di quegli alberi – come di lei – il destino non conosco. Restano le fotografie e la memoria che altro non fanno che testimoniare la sussistenza di un evento, di una storia, di una persona, di se stessi. A chi muore, anche senza lasciare un vero e proprio lutto, non si può parlare, ci si può rivolgere al defunto ma le parole e i discorsi rimbalzeranno tra le pareti della propria mente, divagheranno e creeranno immagini, forse ricordi.
Mi rammento, però, anche di una scritta che lessi sulla panchina dove sedevo.
La panchina, quella rovinata dall’umidità, che era appoggiata al muro pallido del palazzo che sulla piazza non ha finestre. Da questo scanno, dando le spalle al muro scarno si può guardare tutto il campiello, ma questa scritta, dicevo, la lessi perché l’avevo scritta io.
XI
La piazza è fitta di alberelli bassi dai tronchi che sembrano polsi e dai rami che sembrano dita. Il fogliame ha la forma di cilindro, un cilindro dalla base ampia e dall’altezza ridotta. Un cilindro tracagnotto che rammenta uno di quei cappelli da signora che spesso sono di pelliccia o di velluto, i cappelli a tamburello.
Le panchine sono identiche a quelle di altre città che ho precedentemente visitato in questa nazione, ma in questa piazza non c’è musica, solo il brusio costante delle quattro fontanelle ai lati del gazebo centrale sul quale – al sole – oziano piccioni. I passerotti sono tali e quali a quelli europei, ancora non li avevo incontrati in questo viaggio. Si sente ridere e parlare in inglese, anzi in americano, di pochi nodi è la velocità del vento. Il sole tramonta ad ovest e illumina la parte orientale della piazza, questo mi aiuterà ad orientarmi qui.
I rintocchi delle campane della chiesa poco distante ed alla quale dò le spalle mi informano dell’orario.
Mi rendo conto che questa serie di “misurazioni” mi catapulta in una dimensione razionale e matematica senza che io in effetti lo desideri veramente. E difatti, io, qui, non cerco e non voglio punti di riferimento ma mi rendo conto di avere inconsciamente contato i rintocchi, di aver osservato la posizione del sole e di sentirmi leggermente più sicuro, come al riparo, una volta assorbiti questi due suggerimenti casuali. Forse tutto questo interesse ad una localizzazione di me, di dove mi trovo e di quando mi ci trovo è solo dovuto al fatto che qui sono solo, non conosco nessuno e in questa cittadina sono arrivato appena tre ore fa. Guardo in basso i sassolini della pavimentazione scalfita e un po’ invecchiata e sento voci, i passi pesanti di una bambina che corre incerta, lo sbattere di ali di un uccello che prende il volo, il fruscio leggero delle foglie e il silenzio dato dall’assenza di auto.
E così rimango un po’. Guardo la terra.
Alzo la testa, faccio una panoramica di ciò che mi circonda e scopro un altro mondo, quello reale : la bambina che corre ha un volto diverso da come lo avevo immaginato, le foglie mosse dal vento scoprendo il loro lato nascosto mostrano la loro parte più chiara.
Tutte queste informazioni visive oggi, però, sono troppe.
Ho un dolore all’occhio sinistro, quasi mi lacrima. Forse un colpo d’aria preso sul pullman che mi ha portato qui. Lo chiudo, non lo voglio sforzare.
Chiudo anche l’altro, immerso nella oscurità delle palpebre abbassate, nei suoni e negli odori, non mi sento solo, né tanto meno vulnerabile. Aprirò gli occhi quando riconoscerò il silenzio del buio intorno a me.